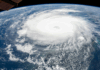Mentre in fabbrica gli operai battevano il metallo e lo piegavano a dovere facendo grande la nostra industria manifatturiera, ancora oggi la seconda in Europa per consistenza, Felice Gimondi menava sui pedali e governava il ferro che lo portava a macinare chilometri in tutto il mondo.
La salita era dura quanto la giornata di un metalmeccanico.
E la discesa era rischiosa quanto quella del piccolo imprenditore che senza alcuna tutela e con una montagna di cambiali si lanciava verso l’impresa.
Era l’Italia degli anni 50′ e soprattutto degli anni 60′.
Un Paese che rivedeva la luce, che si muoveva compatto, che di notte accendeva le luci della ribalta a Via Veneto nel bel mezzo della Dolce Vita, mentre di giorno la vita era meno dolce, uomini e donne faticavano e rischiavano per sbarcare il lunario.
Felice Gimondi era uno di
Nato nella Val Brembana, ciclista per diletto e per lavoro, come era di norma a quei tempi, aveva il marchio della sua gente, i segni della loro fatica stampati sulla fronte, aveva la loro genuinità, che in quel periodo rendeva unico ed omogeneo il nostro paese.
La Val Brembana valeva la Val Trompia, o i Paesi della pedemontana veneta, piuttosto che la Valdarno, la Marsica.
Sempre la stessa storia, di origini umili, di amore per la famiglia, di sacrifici immani, così radicati nell’anima dell’atleta, che lo rendeva uomo prima del tempo.
Uomini che non dimenticavano le sofferenze, anzi continuavano a conviverci, che il successo neanche scalfiva, anzi aiutava a lenire le sofferenze delle persone vicine.
L’uomo era la sua famiglia. La sua famiglia era la sua gente. Il campione correva per il suo popolo, tutti ne beneficiavano, fors’anche per alimentare la speranza che se uno di loro ce
La vera forza era sempre quella di non dimenticare le origini e la propria gente, mai un cenno di distacco, di spocchia, di insofferenza.
Il corridore era l’immagine di un popolo in marcia verso la ripresa dopo le macerie della guerra.
Il campione aveva l’orgoglio di rappresentare la nazione.
Questo era Felice Gimondi, un uomo semplice, concreto, umile, dolce ed al contempo crudo e severo, un campione buono, sorridente sempre pronto alla fatica.
Sempre lo stesso uomo nella buona e nella cattiva sorte. Prima e dopo.
Erano altri tempi, con la maglia rosa e quella gialla sul petto guadagnava poco di più di un ministeriale di buon livello.
A quei tempi il successo lo tributavano le folle e, nel piccolo, i compaesani, più che i soldi. Ed i campioni rimanevano per sempre.
Quando un campione autentico se ne va, ci sentiamo più vecchi, è come se un pezzo della nostra storia, dei nostri ricordi, ci lasci per sempre.
Non correva più Felice, ma aveva corso, ed aveva vinto, da Uomo e da Italiano.
Il sorriso, l’educazione, il rispetto lo rendevano campione nella vita.
Oggi, il campione entra nella memoria, in un angolo di nostalgia che ci rammenta quei tempi, l’orgoglio di un popolo che risorgeva dalle ceneri di una guerra terribile.
Il campione porta con se nei
Ragioni di anagrafe non mi hanno consentito di vivere le gesta di Bartali e di Coppi, poco quelle del caro Felice Gimondi, ma ho avuto la fortuna di vivere a pieno le imprese di Marco Pantani per capire cosa fosse il ciclismo.
Una emozione unica, intensa crescente, l’immedesimazione costante con l’uomo, l’atleta e la sua impresa.
Caro Felice, dopo che ti sarai sistemato in Paradiso, vai a trovare Marco che senz’altro ti sta aspettando, anche perché più di ogni altro saprai offrirgli quell’affetto che tanto gli è mancato su questa terra.
LEGGI ANCHE: