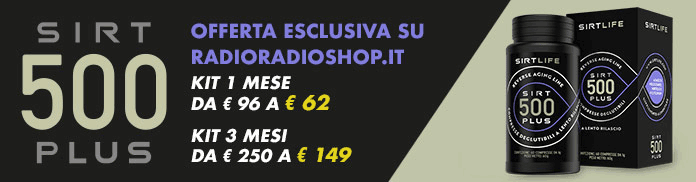Leggo su Repubblica – ma la notizia si trova in molte altre testate – che sono scoppiati e si sono moltiplicati i casi di contratti lavorativi di un solo giorno. Così, ad esempio, dice Repubblica (rotocalco turbo mondialista, voce del padronato cosmopolitico): “Il boom dei contratti di un giorno: +76% cresce il lavoro “spezzatino” e precario”.
Ora siamo arrivati davvero al paradosso massimo: ai contratti lavorativi di un giorno, il non plus ultra della flessibilizzazione del lavoro. Si tratta, a ben vedere, del precariato portato ai suoi massimi livelli. Si tratta altresì della miseria del lavoro presentata nella sua forma iperbolica, più radicale. Eppure – distratti dagli arcobaleni e dai capricci del consumo spacciati per diritti civili – i più non vedono come il capitale, un poco alla volta, si stia prendendo tutto.
Non si prende tutto in una volta – sia chiaro – lo fa gradualmente, un pezzo dopo l’altro, quasi senza che ne accorgiamo, con la conseguenza per cui ci troviamo a regredire giorno dopo giorno inconsapevoli di ciò che sta avvenendo, secondo il principio che Noam Chomsky ha teorizzato con l’immagine della rana bollita, che poi è una presenza immancabile in ogni distopia che si rispetti. E quella che stiamo vivendo è a tutti gli effetti una distopia, che fa apparire Orwell (il massimo ingegnere di distopie) come un dilettante. La realtà lo ha superato in effetti, e riesce a farlo apparire davvero dilettantesco. Rileggere “1984”, il capolavoro distopico di Orwell, fa quasi un effetto rassicurante perché il suo mondo appare tutto sommato un mondo più vivibile rispetto a quello in cui (nostro malgrado) ci troviamo oggi proiettati.
“E se non piangi, di che pianger suoli?” direbbe il Poeta. Come si fa ad accettare silenziosamente questo imbarbarimento del mondo del lavoro? Questa regressione costante? Questa perdita incontenibile di diritti che vengono sacrificati in nome delle ragioni più alte del mercato e della competitività globale? In effetti questo desta maggiore paura: il fatto che il mercato o talvolta i mercati (quando si ridispongono nel discorso del padrone in forma pluralistica e politeistica) siano assunti come la razionalità ultima, come la sorgente di ogni senso dalla quale tutto deve dipendere, compresa la vita degli abitatori della cosmopoli a mercificazione integrale, il regno dell’alienazione, il paradiso dei Robinson immaginati come felici condannati a vivere l’odissea quotidiana della loro solitudine spiazzante. Questo è il mondo del lavoro dopo il 1989, con quelle che sono state e sono tuttora chiamate, incensate, come riforme e che in realtà sono tali solo se guardate dal punto di vista dei gruppi dominanti (in realtà si tratta di controriforme de-emancipative) dacché vanno distruggendo il mondo del lavoro, decomponendo il mondo dei diritti, insomma favorendo unicamente la parte del lavoro.
Dopo il 1989, lo sappiamo, il capitale vincente (sì, perché ha vinto il capitale non la libertà) si riprende tutto. Può procedere disinibito, senza più rendere conto a nessuno. Vince e lo fa riprendendosi tutto, soprattutto andando ad attaccare il mondo del lavoro, cannoneggiando i diritti e le conquiste sociali, decostruendo l’impianto welfaristico ed imponendo ovunque un’unica ratio, quella del mercato, del do ut des, la legge del più forte celebrata come competitività per startupper arrembanti che in fondo, si dice, sono tutti sulla stessa barca chiamati a competere senza alcun anelito di fraternità senza alcun desiderio di cooperazione. Debbono soltanto competere e in questo modo farsi guerra gli uni con gli altri, come in una giungla, come nel bellum omnium contra omnes (la guerra di tutti contro tutti), la scena originaria della modernità codificata da Thomas Hobbes nel “Leviatano”.
Siamo tornati allo status naturae (lo stato di natura) in cui tutti combattono con tutti, in cui la morte del prossimo diventa momento di giubilo perché viene vissuta come un’occasione di profitto, di autoaffermazione a scapito dell’altro. Questo è il capitalismo: che condanna ogni giorno ciascuno di noi, non a vivere ma a sopravvivere alla lotta di tutti contro tutti, chiamato poi (chissà per quale ragione) progresso.