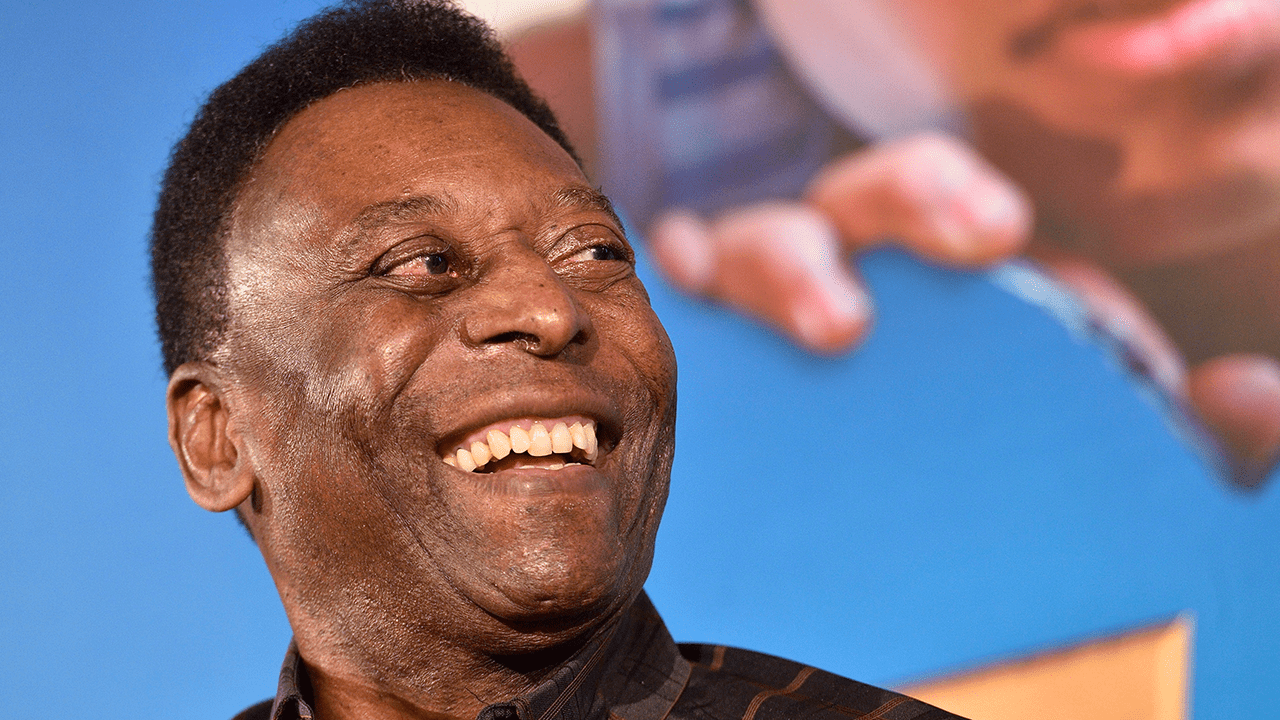Chissà quanti bambini brasiliani, in quell’oceano di lacrime impreviste, avevano fatto ai genitori affranti quella promessa, in quell’estate calcisticamente tragica del 1950: un giorno vincerò io la Coppa.
Il Brasile di Ademir e Barbosa aveva appena consegnato la Coppa Rimet all’Uruguay, in quell’ellisse di sovraffollato dolore che era il Maracana. Anche lui fece la stessa promessa, soltanto otto anni dopo la mantenne, in nome e per conto di tutti quegli altri bambini del suo paese che non avevano smesso di essere poveri; qualcuno non era nemmeno riuscito a diventare ragazzo. Quando dodici anni dopo vinse la terza, definitiva Coppa Rimet per il Brasile a Città del Messico, dolorosamente per un’Italia annichilita dalla perfezione di quella Selecao, ugualmente spese parole contro lo scandalo della povertà, quella dei più piccoli in special modo.
Dopo il dramma calcistico del ‘50, una diffusa corrente di pensiero in Brasile sosteneva che la fantasia, la tecnica naturale, quella specie di prestidigitazione pedatoria che germogliavano sulle spiagge o nelle baraccopoli, rischiavano di non essere più sufficienti, contro il tatticismo granitico delle nazionali europee o contro l’agonismo combattivo di Argentina e, come già dolorosamente sperimentato dai brasiliani, Uruguay. Per qualche anno, il talento dei giocolieri fu considerato quasi una colpa.
Poi accadde che, al Mondiale svedese del ‘58, un signore di nome Vicente Feola, commissario tecnico di un Brasile che attraversava un bivio calcisticamente esistenziale, capì in corso d’opera che vi sono occasioni in cui l’Idea deve arrendersi alla Poesia, con la più nobile delle maiuscole: si ritrovò tra le mani un materiale umano, prima che tecnico, capeggiato da Pelé e Garrincha. Come a dire che dallo sgabuzzino in cui era stata stipata a forza era il caso di tirare fuori di nuovo la “Ginga”, lo spirito naturale di una bellezza primordiale, incarnato nella duplice valenza della Capoeira: modo di lottare dissimulato attraverso una danza; la tecnica combattiva degli schiavi bagnata nell’oro dell’estetica. Quel Mondiale sancì il trionfo del gesto tecnico sulla ordinata muscolarità degli svedesi e di tanti altri. Perché gli altri avevano grandi calciatori, il Brasile si affidava ai “giocatori”, nel senso ludico ed estetico del termine, sublimato dalla massima efficacia possibile. La “Ginga” non è mai stata nemica di alcun ordine, casomai lo ha esaltato. Negli anni a seguire, vedi Spagna ‘82, è capitato che il Brasile la tramutasse in presunzione di superiorità assoluta, ma è un altro discorso.
Lo stesso Pelé ha incarnato la sintesi tra predestinazione tecnica primordiale ed evoluzione tattica e fisica: quando vince il suo terzo mondiale, da trentenne, nel ‘70, il calcio nel frattempo aveva compiuto una serie di progressi da ogni punto di vista e di lì a poco si sarebbe affacciato sulla scena il “Calcio totale” degli olandesi. Lui riuscì comunque a rappresentare un prototipo “futuribile” di calciatore: già atleta nel senso più pieno del termine, è persino riduttivo esemplificare il discorso con il prodigioso stacco di testa in finale contro l’Italia, con Burgnich che assiste impotente al decollo. Mille altri fotogrammi, tra quelli che sono stati ripresi (la minor parte, ed è un peccato quasi mortale), dicono ancora meglio che Pelé è stato “totale” prima di Cruijff. Ma sempre senza prescindere dal retroterra naturale, culturale, etnico e artistico, sì artistico, della “Ginga”, quella che può baciare in fronte anche il più povero e scalzo dei bambini.
Paolo Marcacci