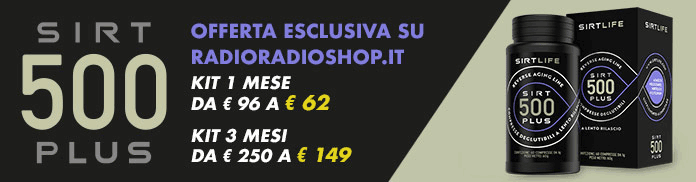Guardate l’espressione di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, dalla quale evapora ogni traccia di tensione agonistica per acquisire i tratti di una empatica preoccupazione, quando Daniele De Rossi gli confida in dettaglio ciò che sta capitando e ciò che si teme.
Guardate i calciatori dell’Udinese che sembrano non avere più la maglia avversaria addosso. Guardate i loro tifosi, sentite l’applauso convinto di uno stadio intero per un calciatore avversario e per la necessità, non curiosità, di conoscere il suo stato di salute.
Fare squadra; anche oltre la squadra stessa, perché hanno iniziato i giocatori della Roma, evidenziando non soltanto la loro apprensione, ma anche la graduatoria delle priorità, quelle dell’esistenza. Anche se nessun telespettatore avesse avuto l’audio a disposizione sul televisore, sono stati subito i volti a “parlare”, lo scenario delle espressioni prima sgomente, poi quasi terrorizzate. Ma quasi subito la preoccupazione è andata oltre la Roma, intesa come squadra, allenatore, tifosi presenti nel settore ospiti del “Bluenergy Stadium”.
Fare squadra, dicevamo, vuol dire tante cose; nella maggior parte dei casi assistiamo a quelle ordinarie, per fortuna: reagire a uno svantaggio, come era da poco accaduto; motivarsi a vicenda, come i giocatori della Roma avevano fatto a San Siro; saper soffrire, in termini quasi sempre tradizionali e riferibili a cose di campo. Oggi no, oggi la sofferenza, i timori e la partecipazione umana il campo lo hanno svuotato.
Tutti quelli che c’erano, e attraverso di loro chiunque stava assistendo alla partita, non avevano più né colore né alcun interesse per un pallone. Quale pallone, a quel punto? Soltanto preoccupazione per un fratello, come in condizioni estreme si sentono tutti gli uomini, salito in una città fino a poco prima avversaria per giocarci – com’è distante, questo verbo, ora – con quel pallone.