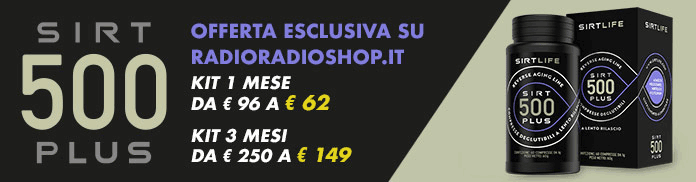Monaco ’84
A ogni giro aumentava un tono, il telecronista brasiliano, come fosse una finale dei mondiali con la Selecao in vantaggio; invece era un giorno di giugno del 1984, di un momentaneo autunno fuori stagione, di nuvole d’acqua soffiate sulla visiera di chi si ostinava a inseguire. È sempre sotto la pioggia, che germogliano i fiori più belli.
Cosa vede Alain Prost? Ha il problema e il vantaggio di guardare davanti, asfalto contorto da arrotolare, bisbigli di classe da sussurrare al motore, per tenerlo buono, chiedendo alle gomme scolpite di procedere a tastoni, capofila di un trenino che a ogni curva artificiale rischia di impazzire, dove ognuno è artefice del proprio destino soltanto fino a che sono d’accordo i freni, la trasmissione, le sospensioni, i centimetri che il cordolo ti concede di invadere. Intanto il telecronista brasiliano, se potesse, scenderebbe a spingere; invece può solo continuare a urlare, soffiando la benzina dei suoi aggettivi sul fuoco della propria incredulità.
Era cominciata da poco ed era già successo troppo: il primo a pensarlo è proprio Prost, dentro la tuta fradicia, che ora non è più così solo, mentre cuce pazientemente ogni curva con la successiva: il francese non ha neanche più il rosso di Alboreto, nei retrovisori miopi, perché una Toleman bianca, con un puntino giallo al centro, sembra protendere l’alettone sempre più vicino ai suoi tubi di scarico. Il pubblico nemmeno la sente più, la maledetta pioggia, protetto dall’adrenalina che un brasiliano semisconosciuto sta comunicando attraverso il volante alla sua monoposto.
Inesorabile come la sorte dei predestinati, la Toleman bianca sembra affilare i denti per azzannare la coda Della McLaren e a ogni cambio di marcia sembra di ascoltare le note di “Singing in the rain”, perché chi è speciale canta e balla sotto la stessa pioggia dalla quale gli altri badano solo a difendersi; c’è un Gene Kelly sotto il giallo fluorescente di quel casco, c’è un sorpasso che impregna l’aria già umida del Principato come uno spettro che a breve si manifesterà, perché la Toleman balla sotto la pioggia, mentre Prost custodisce tra i guanti il pulcino bagnato di un vantaggio sempre più esile.
Bandiera a scacchi, bandiera rossa: troppi colori per lo stesso istante, per il medesimo traguardo: accosta la McLaren di Prost, a qualche metro dal direttore di gara; sfila la Toleman il cui giovane pilota sembra aver vinto, da come alza il braccio; forse il telecronista brasiliano è il primo a capire, forse si ricorda anche che la bandiera non l’ha alzata uno dei tanti, perché il direttore di gara è Jacky Ickx, uno degli dei della Formula Uno tra gli anni sessanta e settanta, uno che corre ancora coi prototipi della Porsche, la stessa casa che fornisce i motori turbo alla McLaren. Sembra che abbia interrotto al trentunesimo giro dopo che Prost gli ha fatto un cenno inequivocabile. Sul podio, più storto dnaso del vincitore è l’umore del ragazzo, che quasi non saluta il Principe Ranieri: ha tutto il broncio della gioventù che si sente defraudata di un qualcosa che gli spetta di diritto, ha tutto l’orgoglio di chi ha gettato il cuore nella sua prima impresa. Spunta il sole di un casco giallo, su un podio di Montecarlo dove un ragazzo di San Paolo sta vivendo la sua alba: per quel poco di gara che c’è stata, il telecronista del suo paese lo ha sempre chiamato per nome: Ayrton.
Monaco ’88, il giro perfetto
È il 14 maggio del 1988, sul circuito di Monaco. Sabato di qualifiche, Senna che gira ormai per battere se stesso perché, come spesso gli capita, gli altri se li è già messi dietro gli scarichi. A un certo punto, però, avverte la pulsione dover girare una volta ancora, come chiamato da una forza superiore. Dev’essere per questo che, dopo, dirà di aver avuto la sensazione di guardare se stesso da fuori l’abitacolo.
Noi, nel mentre, quel giro lo stavamo vedendo e lo avremmo rivisto mille volte ancora, al punto da tornare oggi a raccontarlo. Senza riuscirci del tutto, nemmeno stavolta: come si fa, del resto, a narrare l’inenarrabile? Noi continuiamo a vederlo dentro l’abitacolo, con l’on-board dell’epoca che ancora una volta ci svela, sempre come se fosse la prima, il modo unico che lui aveva di tenere il volante, con quei piccoli scatti infiniti che fanno pensare paradossalmente ai passi centellinati di un equilibrista.
Monoposto di fine Anni Ottanta, ancora col cambio manuale e la frizione, meccanica che ancora prevale sull’elettronica; l’uomo prende per mano la sua McLaren, la migliore di sempre, per farle provare un giro orgasmico, sapendo che non la farà vibrare mai più a quel modo. Rifila un secondo e mezzo a Prost, più di due a Berger.
Dirà, poi, di essersi sentito in un’altra dimensione, tradotta nelle cifre di quell’1’23”998, senza possibilità di provarla mai più nel prosieguo della sua carriera. Dedicato a tutti noi quando ci sentiamo bravi per aver solo fatto qualcosa di decente.
Donington, chiedi alla pioggia
Innanzitutto il primo giro; “quel” primo giro, che passa alla storia come “Il giro degli dei”, quando un irrequieto scenario meteorologico schiude le tende sul palcoscenico del primo giro: Senna parte quarto e resta alle spalle di Schumacher, entrambi superati da Wendlinger; è in quel momento che Ayrton sfrega la bacchetta magica nell’abitacolo: mentre gli altri, tutti gli altri traballano sui rispettivi pneumatici sotto la pioggerella, comprese le due sofisticatissime Williams di Prost e Hill partite in testa, la McLaren spinta dal modesto V8 Ford (un motore quasi “commerciale”, che comunque aveva già vinto a Interlagos) inizia la sua danza, individuando traiettorie laddove le altre monoposto smarriscono le proprie. Via Schumi, Wendlinger, Hill e, in una persistenza di fradicia e impensabile accelerazione, via anche Prost: tutti sulle spalle della McLaren numero otto, prima che la prima tornata abbia termine. È accaduto davvero, anche se a raccontarlo sembra incredibile anche a trentuno anni di distanza.
Chiedi alla pioggia.
Poi, la roulette inglese, con gli occhi verso il cielo: piove, scorci di sole, vento che rende ogni panorama una diapositiva impossibile da prendere in considerazione; ogni pit stop è sempre il penultimo. A un certo punto Ayrton decide di restare in equilibrio sulle slick, consapevole che il cielo ha preparato lo sfondo ideale per tramutare una sua vittoria in un capolavoro. Il gioiello del giro 57, poi, quando un uomo passa per la corsia dei box senza fermarsi, nel tempo in cui ancora non c’è limitazione alla velocità. Un uomo, contro tutte le altre macchine, comprese quelle due Williams, i cui piloti per rivederlo da vicino devono avvicinarlo dai gradini più bassi del podio.
Quando Senna taglia il traguardo, bisogna aspettare quasi un minuto e mezzo per vedere Hill; un giro intero perché arrivi anche Prost.
Chiedi alla pioggia, fatti raccontare di Donington.
Adelaide ’93
Adelaide, Australia, 7 novembre 1993: non è stato soltanto l’ultimo gran premio della stagione, l’ultimo atto di un campionato del mondo dominato in lungo e in largo dalla Williams e da Alain Prost. Adelaide 1993 è anche il punto finale messo alla fine di un racconto che sembrava non dovesse finire mai: quello del duello tra Ayrton Senna e il Professor Prost. Adelaide 1993 è il crepuscolo di due dei, semplicemente perché uno ha deciso, in maniera ormai definitiva, non reversibile, di scendere dall’abitacolo. Nel momento in cui si sfila la maschera, dopo aver tolto il casco, è come se scrollasse dalle proprie esili spalle il peso di un decennio trascorso a cercare razionalmente di raggiungere il limite e di mantenerlo, alimentando ogni volta la ricerca della prestazione perfetta. Contro tutto e tutti, contro ogni imprevisto del quale limitare fino alla soglia del possibile la percentuale di incidenza. Contro Ayrton Senna, soprattutto, che dal 1988 in poi aveva rappresentato il nemico migliore, la sua antitesi, ma anche il suo completamento, il termine di un paragone inevitabile e al tempo stesso quasi eretico.
Sul podio, dopo la cerimonia di rito, Senna chiama, non invita, sul gradino più alto Alain Prost: gli alza il braccio, indicando alla folla, al mondo, il campione del mondo; omaggiandone la carriera che sotto quel cielo d’Australia ha appena consumato il suo epilogo. Ma, soprattutto, Ayrton Senna compie quel gesto per omaggiare chi in tutti quegli anni lo aveva costretto, quindi aiutato, a tirare fuori il meglio della propria classe, della propria determinazione, della propria cattiveria. E chi ti impegna a tirare fuori il meglio, in un modo o nell’altro, ti rende migliore, suo malgrado. Nell’abbraccio che scioglie la tensione, il dio delle corse vorrebbe trattenere il più possibile il tempo dei due, tra i suoi figli prediletti, a cui avrebbe donato l’immortalità agonistica, se solo avesse potuto. Tra loro è appena iniziata l’era del rispetto. Reciproco, come l’odio che si erano sputati addosso a colpi gommando gli asfalti di ogni continente.
Più tardi, Senna confiderà a un amico intimo che solo dopo l’uscita di scena del Professore aveva compreso quanta della sua determinazione era andata perduta per sempre con il ritiro del francese: tutta quella che provava dallo sfidare in pista il “suo” rivale. Suo e di nessun altro. Una forma di amore.
Il sogno di Ayrton
Aveva un sogno Ayrton Senna, un sogno maturato all’ombra del poco tempo che ha avuto in sorte; un sogno via via più consapevole, che avrebbe onorato con la stessa pervicacia, con il medesimo ossessivo perfezionismo tanto detestabile agli occhi dei suoi avversari in pista. Il sogno di un Brasile meno ingiusto, di un’umanità indistinta ed esclusa alla quale tendere la mano per accoglierne il più possibile all’interno del cerchio della dignità. Il suo sguardo, proiettato ben oltre la striscia d’orizzonte sciolta dagli ottani di benzina sulla linea dei suoi tanti traguardi, ha fatto in tempo a lanciare, in modo pratico e in modo simbolico, il suo testimone oltre la barricata tra il suo mondo rarefatto e quello dove i piedi dei bambini calpestano terriccio misto a briciole di pane da non dilapidare. E ancora oggi non c’è bisogno di chiedersi perché in un paese come il suo, che aveva avuto straordinari campioni di Formula Uno, come Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, soltanto lui abbia fatto appassionare alle corse automobilistiche la gente delle favelas malfamate, sovraffollate, affamate e spietate come una interminabile Via del Campo.
Imola, il primo giorno di maggio
“Chiedi a chiunque cosa stava facendo il giorno in cui morì Ayrton Senna: tutti saranno in grado di rispondere” – (Lucio Dalla)
Trent’anni fa. O, forse, un solo giorno: come se il tempo per certe vicende non trascorresse; come se certe sensazioni fossero destinate a non trascorrere. Perché? Perché come esistono i luoghi dell’anima, allo stesso modo esistono i campioni dell’anima, quelli che non abitano soltanto nei ricordi degli appassionati ma anche nelle sensazioni, nitide come all’epoca in cui le hanno fatte provare, che restano immutate.
All’inizio del Campionato del mondo di Formula Uno del 1994, Ayrton Senna viveva egli stesso un passaggio epocale: approdato alla Williams, fino a quel momento scuderia perfetta e imbattibile, si era scoperto ancora più solo, pur essendo stato da sempre un solitario. Non aveva più il nemico del cuore: Alain Prost aveva detto basta, dopo quattro titoli mondiali. Con chi avrebbe potuto, ora, iniziare a interfacciarsi? Per quanto tempo ancora, poi? Forse Senna non lo ammetteva nemmeno con se stesso, ma in fondo sapeva, perché il campione lo sa sempre, che alle sue spalle, senza timori reverenziali, era sorto il pilota del futuro, calpestando a furia di staccate il suo presente: Michael Schumacher era già una realtà, altrimenti non lo avrebbe affrontato così platealmente già al Gran Premio di Francia del 1992. Nel branco ci si fiuta, riconoscendosi a vicenda.
E il Primo Maggio del 1994 cominciava il suo mondiale, dopo due gran premi a zero punti. Pole position, col tedesco accanto, sotto un sole che sembrava già giugno, ma listato a lutto per un sabato maledetto. Si chiamava Roland Ratzenberger, era appena arrivato; il tempo di una stretta di mano con quell’austriaco dai capelli neri, dal sorriso franco. La Simtek si era sbriciolata in un angolo delle inquadrature, sulla destra dei teleschermi, con le telecamere non ancora del tutto posizionate. Poi le gambe scoperte del pilota, il casco piegato di lato, accento circonflesso di un dolore incredulo. La Formula Uno tornava ad aver paura; il campione si era imposto di piangere, in un angolo nascosto del suo box, appena saputo il bollettino medico dall’ospedale di Bologna. Era la sua catarsi di quel giorno da rimuovere, da far poi svanire dentro l’abitacolo della Williams nel quale era stata modificata la posizione di guida, dopo le sue pressanti richieste. E ora il volante era inclinato come lo voleva lui. Come avevano fatto?
- “Non correre domani; piantiamola qui e andiamocene a pescare, hai già vinto tre titoli mondiali – gli aveva detto Sid Watkins, il dottore dei gran premi”.
- “Devo continuare Sid, non possiamo controllare tutto” – aveva risposto Senna.
Quello può farlo solo Dio, in effetti. Lui ci dialogava, sempre, anche mentre fissava le luci del semaforo, prima del via. La mattina, prima dei gran premi, apriva la Bibbia per leggere un passo a caso. Erano i suggerimenti di Dio, che lui riusciva sempre a tradurre. Quella domenica restò interdetto, prima di rasserenarsi; aveva letto che Dio gli avrebbe fatto il dono più grande: Dio stesso.