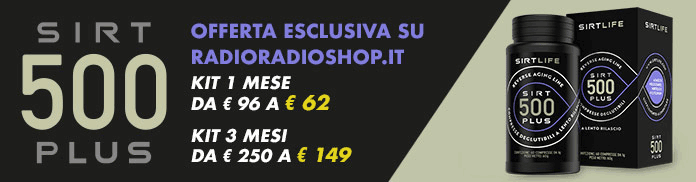La cosa più stupida da fare sarebbe chiedersi, oggi che avrebbe compiuto novant’anni, quanti anni avesse, alla fine; quanto potesse sembrare vecchio, non avendo avuto il tempo di diventarlo.
Chissà se lo riconoscevano ancora, da quando gli era tornato in volto il sorriso sdentato dei miserabili. O, forse, proprio per quello lo riconoscevano.
Dicono che negli ultimi tempi Rio ogni tanto allungasse una mano sconosciuta per offrirgli un giro di bevute, di quelle che da un certo momento in poi avevano cominciato a non fargli più nulla, come se il suo fegato avesse iniziato a vivere di rendita per tutti i calci che lui gli aveva fatto prendere prima.
Cachaça, tre sillabe nella trasparenza di un bicchiere che non riusciva mai a essere l’ultimo, al fondo del quale si rifletteva lo sguardo del bambino che era sempre rimasto tale, perché non aveva avuto la possibilità di esserlo del tutto quand’era il tempo giusto; quello che ogni volta che tirava una pietra la vedeva sparire nella Sierra, a Pau Grande.
Forse per compensare tutti i calci reali che avevano tentato invano di rifilargli dal momento in cui abbozzava la prima finta, caracollando sempre dalla stessa parte, col suo bacino inclinato, quasi a simboleggiare gli squilibri di un modo di vivere che non riusciva a stare in asse con con una serenità che potesse durare più di qualche ora; con quelle ginocchia sempre in antitesi fra loro, da una parte la rientranza che tracciava la metà di una ics, dall’altra una specie di arco verso l’esterno, per poggiare un destino malfermo che sarebbe rimasto in piedi finché fosse stato in grado di resistere alle entrate sempre più dure dell’autolesionismo.
Quell’arco strabico come un passaggio obbligato sotto il quale l’uomo un tempo celebre si vedeva piovere addosso i calcinacci dei giorni che nessuno gli avrebbe mai restituito, sui quali non avrebbe avuto nemmeno il tempo di recriminare; forse alla fine nemmeno rimpianti, come Il suonatore Jones di De André, che in un vortice di polvere vedeva i volteggi di Jenny che ballava, quando tutti gli altri vi leggevano un presagio dì siccità.
Perché era la vita stessa di Mané Garrincha a zoppicare lungo il cammino, nel corso del quale le vittorie non hanno fatto altro che prendere i suoi demoni più strettamente sottobraccio. Dicono che Manè, all’indomani della seconda Coppa Rimet che s’era portato a letto, poggiando sul comodino il titolo di capocannoniere, abbia chiesto ai compagni contro chi avrebbero dovuto giocare la partita successiva. Forse è soltanto una leggenda; di certo chiunque l’abbia ascoltata ha pensato che sarebbe potuto accadere sul serio, all’indomani di una sbronza mondiale.
La gloria, della quale forse non si rese conto del tutto, come una puttana troppo truccata, gli sorrideva mostrando denti che apparivano già anneriti agli occhi degli altri, tutti quelli che lo avrebbero compatito dopo. Sempre dopo. Come il denaro, che può essere così tanto, quando arriva tutto assieme, al punto da renderti incapace a contarlo. Soprattutto se ti resta la faccia di chi ne aveva soltanto sentito parlare, sotto gli abiti costosi che ti pesano addosso come un’armatura.
O come una gabbia, che non c’è regalo più bello del poterla aprire, per un battito d’ali che vale una Coppa del mondo. Ma quella è una storia che sapete tutti, e Manè Garrincha si annoierebbe a sentirla ancora una volta.
Il miracolo fu quello della gioia, l’unica cosa a restare sempre intatta negli occhi di chi lo vide giocare; lui che la distribuiva senza esigere nulla in cambio; moltiplicata dai sorrisi di chi non potrebbe mai permettersela, se dovesse pagarla di tasca propria.
Mané sapeva distribuire l’oro ai poveri, perché non aveva mai cessato di essere uno di loro, lo aveva capito ancora meglio quando s’era arricchito. Gli era sempre venuto più facile moltiplicare la gioia degli altri che tenersene un poco da parte per sé, come tutti quelli che tornano nella bettola del paese dal quale sono partiti e si svuotano le tasche a forza di chiamare l’ennesimo giro per tutti gli amici, anche quando tali non sono.
Forse nemmeno si accorse di non essersene tenuta nemmeno un poco per sé; allora non gli restò che arrendersi a contemplarla negli occhi degli altri, di tutti gli altri, laddove i più poveri ancora riescono a distinguerla dall’ammirazione: quella tocca a chi ha la faccia del vincitore.
Ci sono vite troppo piene di ogni cosa, per pretendere che possano anche contenere una qualche serenità; così come ci sono azioni così belle, con l’ultimo dribbling rimasto nel taschino persino davanti alla riga di porta, che il tiro in porta sembra quasi mortificarle. Per quello, in ogni caso, ci avrebbe pensato Pelè. Loro due assieme non hanno mai perso una partita con la Seleçao, vincendo la Coppa del Mondo del ‘58 e quella del ‘62 e segnando un gol a testa l’ultima volta che sono scesi in campo assieme, il 12 luglio del 1966, al Goodison Park di Liverpool, Mondiale del 1966.
Una punizione di Pelé, poi una di Garrincha, con una parabola prodigiosa d’esterno, più arcuata di una delle sue gambe, a scelta, a seconda della prospettiva. Il loro Brasile era stato come il parroco di “Bocca di rosa”, che s’era portato in giro per il mondo l’amore sacro e l’amor profano.
Diversamente eterni, oltre ogni soglia biografica ed esistenziale; a Garrincha sarebbe mancata per sempre la consapevolezza che Pelè ha sempre avuto circa la propria grandezza. A Pelè, sarebbe per sempre mancato il compagno capace di ricordargli, per ogni zolla miracolosamente inventata verso la linea di fondo, quella specie di magia che ogni tanto schiudeva le porte del paradiso anche per i miserabili, per gli ignari, per gli zoppi. È per questo che al cospetto di Pelé tutti si toglievano il cappello; per Garrincha, hanno sempre trovato una lacrima da asciugare.
Lo videro zoppicare al di fuori della linea laterale anche alle porte di Roma, a Sacrofano, quando gli venne in mente di giocare con i dilettanti per rimediare qualche soldo e ritrovare quella felicità che lo faceva sentire protetto all’interno del rettangolo, l’unico posto al mondo dove nessuno riusciva a fargli del male. Chissà se anche da quelle parti si annoiava a far cadere quella finta sempre dallo stesso lato, sapendo che sarebbe rimasta impressa nella retina del suo presunto marcatore, senza mai finirgli sui piedi che avrebbero continuato a calciare l’aria. Forse con lo stesso rumore di quell’uccellino tropicale al quale doveva il suo soprannome, per il saltellare asimmetrico che li accomunava.
“Anvedi, pare Garrincha…” devono aver pensato vedendolo, ventre gonfio e andatura claudicante quando la palla non gli era accanto. Anzi: “Garincia”, nella pronuncia locale stupefatta come ogni volta che un prodigio si manifesta dove mai ce lo si immaginerebbe.
La notte del 20 gennaio del 1983, forse anche a causa dell’afa quasi insopportabile, le dottoresse Da Cunha e Bastos fanno portare per il paziente una sedia a rotelle, visto che non gli riesce di deambulare. Nemmeno zoppicando. Chissà se da una delle finestre dell’ospedale Alto Da Boavista riesce a vedere le luci di Rio. I medici lasciano detto di legarlo, all’occorrenza, se dovesse dare in escandescenze.
Capita di frequente, del resto, al padiglione Santa Teresa, quello riservato agli alcolizzati. Alle sei del mattino, le luci di Rio si spengono, per Manè Garrincha. Ha quarantanove anni; ne dimostra venti di più; ne ha vissuti mille.
Se un qualche dio ha voluto accompagnarlo fuori dal campo, magari prestandogli una spalla alla quale appoggiarsi per zoppicare un po’ meno, gli avrà pur chiesto se si sia mai pentito di qualcosa, Manoel Francisco dos Santos, detto Garrincha.
Inconsapevole anche di andarsene, Mané, stordito come uno sgabello che poggia male le sue gambe, davanti a un bancone dove gli ubriachi non distinguono più se sia pessimo o eccellente il liquore che continuano a chiedere, alzando gli occhi avrà accennato l’ultimo sorriso inebetito, forse immaginando di vedere dentro una cornice misera, sulla parete, la maglia ingiallita del Botafogo.
Paolo Marcacci