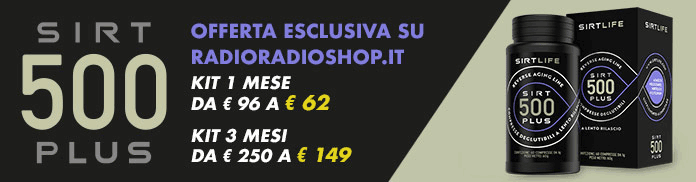Le storie degli altri, tanto o poco che sia, saranno sempre deformate dal nostro sguardo, ogni volta che le giudicherà, senza volerlo, anche soltanto per l’intenzione di raccontarle. Forse, per questo, lui ci ha tenuto a precisare le parole, finché gli sono bastare: quelle da utilizzare e quelle da escludere, ogni volta che si trattava di descrivere il male che lo aveva colpito; per ogni occasione in cui sentiva o leggeva qualcuno che, in buona fede, magnificava la sua lotta e il suo modo di combattere. Proprio in quei frangenti precisava che le metafore della lotta e del combattere sono le meno centrate in assoluto, perché quando il destino, la natura o chi per essi ti fischiano contro quel tipo di rigore, puoi soltanto sperare che finisca fuori, più che impegnarti per pararlo.
Lo faceva anche in nome e per conto di tutti quei poveri cristi e quella gente comune alla quale nessuno avrebbe mai chiesto se e come stessero combattendo contro il tumore; oppure quanto, sbagliando un poco di più la domanda. Il paradosso, se ripensiamo alla nostra metafora di qualche riga fa, è che lui i rigori li tirava e avrebbe voluto avere la possibilità di farlo anche in quella sera di maggio del 1992, a Wembley, quando la sua Sampdoria era sul penultimo gradino della scala dalla quale sfiorava con le dita il tetto d’Europa, fino all’ultimo giro di lancetta supplementare, quando il pallone calciato da Koeman del Barcellona mandò in frantumi la scala e tutti i sogni blucerchiati che vi si erano arrampicati. Un esempio del destino quando non si distrae, o del caso quando si presenta all’appuntamento senza nemmeno averlo deciso. O della malattia inesorabile che non si stanca di corrodere la vita, l’unica cosa sulla quale lui aveva precisato di poter contare, fino ai giorni in cui aveva preso atto non di una battaglia persa, ma di un tempo ormai esaurito: il suo, che era stato pieno di tutte quelle cose che anche gli altri ragazzini di Cremona sognavano sin dalle partitelle all’oratorio.
La Cremonese il primo amore; la Sampdoria una giovane moglie che sarebbe stata amata per sempre; la Juventus ammaliante signora che in un modo o nell’altro sarebbe comunque riuscita a sedurlo; il Chelsea un amore maturo consumato tra i clamori di Stamford Bridge, dove la pronuncia del suo nome continuerà ogni volta a portare in alto i boccali. A tutte ha lasciato in dote trofei come figli conquistati in comune, nazionali e internazionali, sempre facendo l’amore con il gol, 259 in 673 partite, complessivamente.
Ciò che non è riuscito a donare alla maglia azzurra, pur avendolo meritato soprattutto in quell’estate italiana del 1990, lo ha restituito con l’abbraccio a Roberto Mancini l’11 luglio del 2021: lui magro, sfibrato ma entusiasta; il compagno di sempre grato per l’attraversamento in comune di quel penultimo tratto di strada. C’era ancora Wembley di mezzo, a restituire i rigori di ventinove anni prima.
Era chiaro che la sua scomparsa, prematura e drammatica, avrebbe fatto riaffiorare questioni ombrose come quella dei sospetti di doping legati in particolare al processi contro la Juventus della quale fu uno degli alfieri, nella seconda metà degli anni Novanta, e in generale a tante morti premature del calcio italiano distribuite nel corso dei decenni passati. Anche di questo si era tornati a parlare al momento della sua scomparsa. Anche a sproposito, o per sentito dire, cosa che è sempre accaduta e che nella nostra epoca ha una cassa di risonanza molto più amplificata. Per quanto ci riguarda, crediamo che onorare davvero un’esistenza, al di là di quanto prestigioso sia stato il vissuto che l’ha accompagnata, significhi contemplarne anche i chiaroscuri, i momenti meno fulgidi.
Lui era Gianluca Vialli. L’uomo non c’è più, da due anni. La sua storia, grandiosa per le imprese sportive e grandiosamente dolente dal lato esistenziale nell’ultimo tratto, è ancora qui. Avrà sempre un senso continuare a raccontarla.
Paolo Marcacci