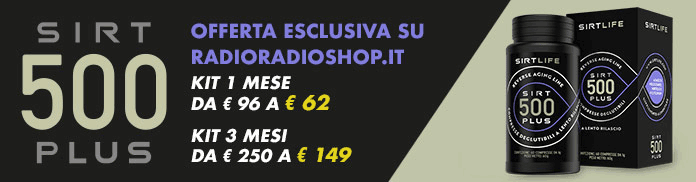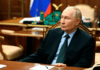È stato lasciato solo dalle stesse Istituzioni, dal popolo, dai media. In questo mese stanno celebrando l’anniversario della sua morte come un rituale propiziatorio di estenuante lotta alla mafia ininterrotta ormai da 30 anni, come un memoriale necessario quando (agli occhi e orecchie di chi sa) è solo un semplice atto di ipocrisia da parte di chi lo ha spedito dritto nelle mani di Cosa Nostra il 23 maggio del 1992: “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande”. Si sentiva così Giovanni Falcone, alla fine.
E la sua morte, assieme a quella della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è stata premeditazione, strategia, necessità da parte di chi lo definiva un magistrato scomodo. Lo stesso magistrato che aveva partecipato alla creazione di un pool antimafia, un’unica organizzazione che combattesse la criminalità organizzata, dalla simile percezione scomoda. Sì, perché prima di lui, di Rocco Chinnici, Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto le indagini di mafia erano decentrate, illusorie e non portavano da nessuna parte se non a definire la mafia stessa come un fenomeno perlopiù inconsistente e gestito da criminali di poco conto. Una visione comoda per chi, dal potere mafioso, traeva benefici economici e non. Il pool, attivo dal 1983, aveva l’obiettivo di tagliare quel cordone ombelicale che per tutto il XX secolo si era fatto sempre più consistente, legando con un filo rosso potere mafioso, economico e politico.
Falcone ebbe il suo primo vero approccio al fenomeno mafioso con il Processo Licari nel 1967. Il processo contro le cosche del Trapanese aprì la via a ciò che oggi è storia: l’approccio costituzionalmente etico di Falcone promosse un modus operandi unico e risolutivo nelle indagini del tempo. Seguire gli accertamenti bancari e rispettare allo stesso tempo i diritti fondamentali della persona era la chiave per sconfiggere la mafia. Rinominato poi come il ‘Metodo Falcone’, costituì parte fondamentale del famoso Maxiprocesso, che vide al suo interno, a partire dal 1986, 475 imputati. Seppur la sentenza finale della Corte di Cassazione si ebbe il 30 gennaio 1992, ricordiamo che il processo di primo grado, terminato nel 1987, si concluse con 19 ergastoli e pene detentive da 2665 anni di reclusione. Una vera e propria rivoluzione nel panorama del processo penale italiano, soprattutto in virtù del fatto che il magistrato passò da un modello processuale accusatorio a contraddittorio con successo.
Se da una parte dell’opinione pubblica e della politica, questa svolta storica suscitò speranza e stima nei confronti della magistratura, dall’altra ci si stava spingendo troppo oltre: il sistema economico e politico non era ancora pronto per una svolta di simile portata. E nei suoi ultimi anni di vita Falcone lo aveva capito benissimo: alla nuova nomina di Capo dell’Ufficio di Istruzione di Palermo nel 1988, prevalse il magistrato Antonino Meli, non proprio centrato nelle inchieste mafiose. Così, relegandolo a fare inchieste meno “complicate”, lo spogliarono di quel rilievo giudiziario che si era costruito faticosamente in riferimento lotta alla criminalità organizzata, lasciandolo isolato nel mirino di Cosa Nostra, costringendolo inoltre a trasferirsi a Roma. L’epilogo ormai lo conosciamo tutti.
La memoria come fonte di cambiamento: le testimonianze dirette
Oggi si ricorda la sua morte, ma è ancor più importante ricordarne la vita nei suoi momenti più belli e le iniziative che continuano a mantenere viva la sua memoria, non solo il 23 maggio di ogni anno. Michele Prestipino, Procuratore aggiunto di Roma, è intervenuto durante le tre giornate dedicate alla lotta alla mafia organizzate dall’Università di Roma La Sapienza del 16-17-18 maggio 2022, e si è battuto proprio per questo: creare un ponte tra il passato e il presente in maniera più consapevole e continuativa, soprattutto tra le nuove generazioni: “Molto è cambiato del metodo e della mentalità mafiosa”. Evidenzia il Procuratore, ponendo l’accento su un fattore interessante: “Oggi c’è meno mafia fisicamente parlando ma stiamo assistendo a un’espansione del metodo”. Metodo che vede più disponibilità liquida, espansionismo territoriale e che, provandoci come allora, il procuratore cerca di combattere. Assieme a lui sono intervenute altre figure di spicco nel panorama attuale antimafia, come lo storico Enzo Ciconte, l’attivista Tina Montanaro (moglie di Antonio Montinaro), il giornalista Lirio Abbate e Franco La Torre, figlio di Pio La Torre (quest’ultimo vittima di mafia perché ideatore del 416 bis, la norma che definisce l’associazionismo mafioso).
“Ci rivolgiamo a voi, voi dovete essere diversi da noi, curiosi e fare delle domande. Se veramente dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo farci anche delle domande e tutti quanti metterci in gioco se davvero vogliamo un paese diverso e che certe cose non accadano più”. Queste le parole di Tina Montanaro, volte ai futuri magistrati, politici, giornalisti. Evidenziando così come la memoria deve essere funzionale al cambiamento.
Aggiunge poi Franco La Torre: “Il problema è che un fenomeno come la mafia si può sicuramente su una memoria soggettiva, quella che portiamo noi ad esempio, familiari delle vittime innocenti. Ma il fenomeno di classi dirigenti, quel sistema di potere, economico e criminale. Queste sono le definizioni che dava mio padre della mafia. Non lo si può comprendere a pieno se non lo si osserva da diversi punti e cioè dove quel sistema di potere si colloca e agisce. Il limite è che da un po’ di anni a questa parte la narrazione dominante è quella giudiziaria, fa un lavoro pressoché quotidiano e con successo ma ancora una volta questa narrazione dominante ci restituisce un pezzo della realtà mafiosa. Che non è agita soltanto da persone di bassa statura e con i baffetti che si esprimono in dialetto e scrivono bigliettini.
In questi 161 anni di storia di Unità di Italia, lo stragismo mafioso è limitato a una parte molto minoritaria perché l’obiettivo della mafia è l’accumulazione illecita non le stragi. Ricorre alle stragi quando c’è un disegno eversivo. È un’organizzazione criminale che si nutre di politica e economia. Tutti riuniti a tavolo per accumulare illecitamente e controllare i meccanismi di potere, il processo decisionale. Ci dobbiamo riappropriare, per memoria, di quegli strumenti che sono in grado di leggere questo fenomeno nella sua complessità. Sennò continuiamo a inseguire Totò Riina, non essendo investigatori e magistrati. Abbiamo un altro compito. Io vorrei che mio padre fosse ricordato per la sua vita, non per la morte”. Mantenere perciò viva la memoria per non ripetere gli errori del passato. Collocare la mafia solo all’atto violento sanguinario è riduttivo: combattere partendo dalla memoria, non fermandosi ad essa.
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici e altre vittime di mafia come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giornalista Peppino Impastato, il politico Piersanti Mattarella e non solo, rimasero fedeli all’etica costituzionale e allo Stato per combattere la criminalità organizzata, fino ai loro ultimi respiri. Si può dire che lo stesso Stato abbia avuto riguardo nei loro confronti? A voi la risposta.
Elena Duranti