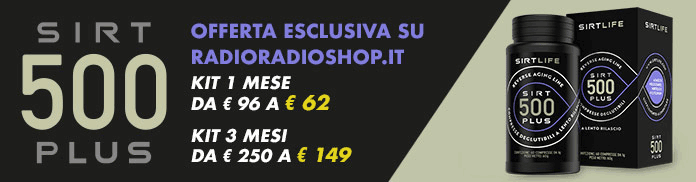Dopo aver analizzato alcune tra le proposte di uscita dalla moneta unica, bisogna rispondere alle domande riguardo alle conseguenze che una tale fuoriuscita potrebbe avere.
Non è semplice prevederne gli scenari successivi, molto dipende da due fattori: la possibilità che l’euroexit coinvolga uno o più paesi e il peso economico-politico degli stati che hanno “battuto questa strada”.
Rimanendo nel campo degli approcci scientifici, alcuni economisti sono al lavoro su complessi modelli previsionali. I fondamenti di teoria economica insegnano che la fuoriuscita di un paese dall’euro e il ritorno alla vecchia moneta, con un cambio iniziale di uno a uno, dovrebbe portare subito ad un deprezzamento della nuova moneta che diverrebbe così a buon mercato rispetto alle altre valute. Ciò dovrebbe favorire le esportazioni del Paese e limitarne le importazioni, migliorando il saldo della bilancia commerciale, spingendo così la crescita ed una maggiore occupazione.
In che misura però l’abbandono degli accordi di cambio e le svalutazioni aumentino effettivamente la crescita è ancora oggetto di infinite dispute. La svalutazione aumenta il costo dei beni importati e per questa via tende a incrementare il livello dei prezzi interni, quindi il prezzo delle stesse esportazioni, riducendo il vantaggio competitivo. A complicare le cose, si aggiungono gli effetti redistributivi della svalutazione. L’aumento del livello generale dei prezzi interni che tende a seguire la svalutazione porta, ad esempio, a ridurre il potere di acquisto dei salari monetari. La riduzione dei salari reali può generare, in presenza di meccanismi di adeguamento dei salari ai prezzi, una pressione al rialzo dei salari, in questo caso, monetari e ciò potrebbe accentuare l’inflazione, erodendo maggiormente il vantaggio competitivo della svalutazione.
Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione, attraverso uno studio accurato, hanno considerato la debolezza dei modelli previsionali focalizzandosi, invece, sull’esperienza storica. Essi hanno identificato importanti indicazioni dalle crisi valutarie passate, per quanto nella storia non si è mai registrato un evento paragonabile alla rottura dall’euro. I due autori sono partiti dall’analisi di quelle crisi valutarie che vanno dal 1980 in poi e che hanno comportato ampie svalutazione del tasso di cambio, accompagnate poi ad abbandoni di precedenti sistemi di cambio. Hanno rilevato che esistono ben 28 casi di ampie svalutazioni (di cui ne prenderemo solo alcuni come esempio), superiori al 25% rispetto al dollaro, e che hanno comportato la rinuncia ai precedenti sistemi di cambio.
Effetti sulla bilancia dei pagamenti:
Gli studiosi hanno inizialmente registrato che abbandonando l’euro come valuta principale un primo effetto benefico si riscontrerebbe nel miglioramento della bilancia dei pagamenti, conseguente l’aumento delle esportazioni a scapito delle importazioni. I due autori hanno però notato che questa previsione non si è realizzata. Operando il confronto tra la media del saldo della bilancia commerciale rispetto al Pil nei due e tre anni precedenti e successivi la crisi, Realfonzo e Viscione hanno osservato che i paesi a basso reddito non hanno tratto grandi vantaggi dalla svalutazione. La tabella dice che le esportazioni e importazioni si sono mosse di poco.
Saldo della bilancia commerciale – Valori medi rispetto al Pil nei due e tre anni precedenti e successivi alla crisi del 1980-2013:

Diversa la situazione negli altri paesi, cioè quelli con reddito più alto, nei quali la conseguenza della crisi, invece, ha avuto un effetto benefico sul saldo della bilancia commerciale. A fronte di ciò, i miglioramenti di quest’ultima dovrebbero impattare positivamente sulla crescita. In realtà, per l’insieme dei 28 casi considerati non si registrano risultati positivi. Infatti, i due analisti, dividendo i paesi ad alto reddito da quelli a basso reddito, ancora una volta, hanno riscontrato effetti opposti.
Saldo della bilancia commerciale – Valori medi rispetto al Pil nei due e tre anni precedenti e successivi alla crisi del 1980-2011:

Come si può notare dalla tabella qui di sopra, a differenza dei secondi, i primi hanno registrato un aumento significativo del tasso medio di crescita, passando dall’1,2% dei due anni antecedenti alla svalutazione al 2,2% dei due anni successivi. Un’ulteriore accelerazione della crescita si è avuta nei tre anni precedenti e successivi, allorché essa è passata dall’1,4% al 3,2%. Complessivamente, quindi, i paesi ad alto reddito, spinti dalla bilancia commerciale, hanno aumentato i ritmi di crescita.
Senza incappare nell’errore di generalizzare, i due autore hanno però notato che non tutti i paesi ad alto reddito hanno seguito questo trend, tra questi abbiamo l’Italia. A seguito di alcuni aspetti positivi che toccavano la competitività, il saldo della bilancia commerciale e la crescita, Realfonzo e Viscione constatarono che questo discorso non valeva per ciò che concerne gli effetti delle crisi sul livello occupazionale: in tutti e 28 i casi si osservò che il tasso di disoccupazione in media si riduceva di un punto dopo tre anni dalla crisi. Tuttavia, tale calo interessava i paesi a basso reddito, in particolare si riscontrò in misura maggiore in Spagna e Italia dove il tasso di disoccupazione crebbe maggiormente, mentre negli altri la disoccupazione prima salì lievemente e poi ritornò al livello antecedente.
Conseguenza sui salari
I due studiosi hanno, infine, analizzato cosa potrebbe bloccare una ripresa occupazionale all’indomani dell’euroexit, con riguardo agli effetti dei salari. È qui che sussiste la preoccupazione maggiore, in quanto il passato mostra come le conseguenze sui salari possono essere particolarmente gravi. Essi hanno considerato sia la variazione percentuale dei salari reali, cioè il potere di acquisto dei salari monetari medi dei lavoratori, sia la differenza percentuale della quota dei salari sul Pil, che mostra quale sia il valore percentuale del prodotto interno lordo che va a coloro che percepiscono redditi da lavoro.
Nei primi tre anni dopo la svalutazione si assiste a un forte calo dei salari reali e della quota salari sul Pil, che appare essere principalmente la conseguenza delle pressione inflazionistiche che generano una redistribuzione dai salari ai profitti e alle rendite. A riguardo può essere significativo ricordare il caso italiano: dopo la crisi valutaria del 1993 furono messe in atto politiche salariali restrittive, ciò limitò la spinta inflazionistica, permettendo alle esportazioni di continuare a crescere, determinando però una caduta dei salari dopo tre anni di oltre il 4% e un crollo della quota salari che sfiorò il 9%.
Il che spiega il calo della domanda interna e la mancata crescita del nostro paese in quegli anni, oltre alla maggiore disoccupazione. In altre parole, alla luce dei dati sulla crescita del saldo della bilancia commerciale e della diminuzione dei salari reali, in Italia l’aumento della domanda estera venne compensato dal ristagno di quella interna con effetti nulli sulla crescita.