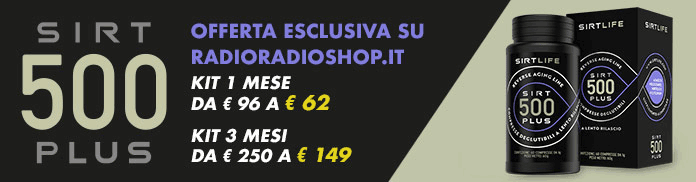– Ma chi sei, Mennea? -: si dice ancora oggi, come luogo comune, quando si vede qualcuno a passo spedito, o fare qualcosa in maniera particolarmente rapida. Come se il suo nome fosse quasi entrato nel linguaggio comune. Anzi, senza quasi: lo usano, come similitudine, anche i giovanissimi, quelli che proprio non c’erano, non erano nemmeno pensati, quando le sue accelerazioni fiaccavano i giri delle gambe di atleti più poderosi, più alti, più prevedibili al traguardo.
Diciannove e settantadue: scritto in forma di parola, come fosse un verso da declamare; il suo record sui duecento metri piani a Città del Messico, sintesi di doti non comuni in un velocista apparentemente comune; compendio del suo dieci e zero-uno (ci piace così) con cui aveva quasi accorciato i cento metri. Preludio, anche, a Mosca ‘80, una medaglia che seppe luccicare, comunque, da ogni lato del Muro di Berlino. Quel diciannove e settantadue avrebbe dovuto attendere Michael Johnson nel 1996, prima di farsi archiviare nel libro dei record, non nella memoria, anche quella tramandata per via di racconti e filmati, di una nazione che nel nome di alcuni sportivi trova sempre, a distanza di anni (esattamente quaranta, oggi) un non contaminato motivo di orgoglio.
– Ma chi sei, Mennea? -: sentiremo chiedere, anche tra dieci anni, sempre ben conoscendo la risposta: no, perché ce n’è stato uno solo.
Paolo Marcacci