Atlanta, 1996. L’uomo in tuta bianca, ultimo tedoforo prima dell’apertura del braciere, appare alla folla con l’espressione di una stralunata felicità. Rigidi i muscoli del viso, gli occhi scintillanti, che fissano un punto lontano, come a voler acciuffare, tutte insieme, la gioia, la commozione, la solennità di un istante, come tanti ve ne sono stati nella sua vita; una vita che torna a incoronarlo. L’Olimpiade deve ancora iniziare, eppure ha già impresso negli occhi del mondo il suo fotogramma più prezioso e prestigioso. Ad Atlanta, in Georgia, dove soltanto trent’anni prima un nero avrebbe avuto problemi a trovare un bagno pubblico che non gli fosse precluso, o un bancone decente al quale appoggiarsi per ordinare un caffè. O dove, anche in quell’occasione si era trattato di un paradosso, all’epoca ancora più beffardo per l’America razzista, era ricominciata la sua carriera dopo il lungo esilio. Muhammad Ali tiene la torcia con il braccio destro, stringendola al punto tale che sembra voglia frantumarla. Trema, visibilmente, la mano sinistra e per questo il campione tiene faticosamente a bada il braccio basso, vicino al corpo. Il coronamento della sua leggenda, un palco illuminato sul mondo e per il mondo stesso l’occasione di dichiarargli il suo rispetto. Non è un’impresa facile, per lui: a tratti la fiamma è troppo vicina agli occhi, mentre il corpo vibra e si scuote per lo sforzo. Diventano persino più solenni, quindi non contaminati da alcuna commiserazione, quegli istanti che fanno il giro del mondo, come gran parte dei momenti della sua esistenza. Lo capisce la folla sorpresa, perché fino all’ultimo momento la notizia era stata celata, salvo qualche indiscrezione: non è un’ovazione, quella; è un boato quasi isterico, di sorpresa e commozione subitanee, di grande amore rimasto intatto e preservato dal tempo, dalla consunzione, dalla malattia che trascina via, un millimetro alla volta, una grande anima da quel corpo che era stato il tempio delle sue doti inimitabili. Troppe volte scosso, quel tempio non era mai venuto giù: in nessuna foto lo si può vedere al tappeto, come se tutti quelli che lo hanno sperato per una vita dovessero ora arrendersi al fatto – e al fato – che il loro odio di un tempo si era tramutato nell’incantesimo della sua longevità atletica, prima; quindi, una volta sceso definitivamente dal quadrato, di una popolarità planetaria, non fine a se stessa, che ormai si stagliava al di sopra anche dei dissensi di un tempo. Come disse un vecchio per la strada a Lloyd Wells, un giorno in cui quest’ultimo accompagnava Ali a una conferenza: – Che diavolo, lo amano persino quelli che lo odiano! –
Non nomineremo la malattia di Ali, in queste righe, né ricostruiremo l’iter delle diagnosi, delle cure efficaci o dei cialtroneschi palliativi ai quali si è sottoposto. Non la nomineremo anche perché negli anni, e nel corso delle ipotesi, quella malattia ha conosciuto anche l’evoluzione della sua definizione, oltre che quella dei sintomi sempre più manifesti. Anche il male è stato un lungo viaggio, un mondo da attraversare come tutti i paesi che Ali ha visitato e in cui ha rappresentato una certa America, una serie di ideali per i quali battersi, la speranza di cambiare le cose, almeno in parte, grazie al suo carisma. Non ha mai rappresentato soltanto se stesso: questa è stata la ragione principale della sua grandezza; per questo ha continuato a lottare, imponendo a se stesso, al suo corpo via via più scollato dall’anima, il dominio dell’orgoglio. Il giornalista Gary Smith, nell’inverno del 1988 va a trovare Ali per un reportage; dopo l’intervista quest’ultimo gli propone di assistere a un suo allenamento: boxe con l’ombra e lavoro al sacco, per dimostrare di essere ancora in grado di reggere allo sforzo fisico:- A restarmi impressa, però, fu la sua difficoltà nell’entrare e uscire dalla stanza. La porta era chiusa e Ali impiegò parecchi minuti a infilare la chiave nella serratura e aprirla. Eppure non si lasciò scoraggiare, né inventò alibi: continuò a insistere. Incuteva rispetto quell’ostinazione. Reagiva alla malattia con grande dignità. Una cosa era chiara: non si sarebbe arreso finché non fosse riuscito a portare a termine l’impegno che si era prefisso. Così, quando mi chiedono se abbia provato pena per Muhammad Ali, la risposta è no –.
Paolo Marcacci













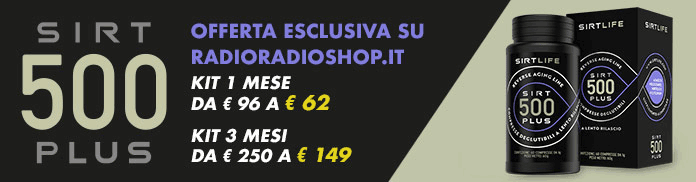


![Putin smentisce tutti sugli ATACMS – “nessun danno” – e avverte NATO e Stati Uniti [Sub. Ita]](https://www.radioradio.it/media/2024/11/putin-guerra-100x70.png)







