Non sappiamo, non possiamo dirlo, dove finiscano le immagini e dove inizino le note. Di certo, le prime non sarebbero state le stesse, senza le seconde. Perché le note erano le sue e hanno vestito qualsiasi pellicola che, specchiandosi alla fine del montaggio, si è ritrovata più bella.
Sin dalla prima visione non siamo più stati in grado di disgiungere lo sguardo di Clint Eastwood sotto il cappello impolverato dalle note secche, quasi sospese, che sembravano attendere lo spettatore come il serpente a sonagli dietro un sasso del deserto, alle porte di un qualche avamposto di frontiera. E Totò che scopre il cinematografo grazie alle pellicole regalategli da Alfredo non possiamo che fischiettarlo come faceva lui, quando saliva nella sala di proiezione del “Paradiso”.
Non ti chiamano “Maestro” perché riempi una mensola di statuette da Oscar; quell’appellativo lo si merita quando un pubblico intero, moltiplicato per generazioni, capisce che hai parlato, attraverso uno dei molteplici linguaggi dell’arte, a nome suo, per mezzo della tua opera.
E tutti siamo stati Noodles, almeno una volta, traditi da un amico dal quale non potevamo aspettarci altri; tutti abbiamo amato una Deborah mai appartenutaci, per rincontrarla prima o poi, ma sempre troppo tardi. E le note di Ennio Morricone hanno sussurrato le parole che i dialoghi non hanno saputo trovare; hanno puntato gli sguardi dei protagonisti al centro dell’anima nostra.
Passano, trascorrendo, i suoni di ogni spartito, fino all’ultimo inchino dell’orchestra. Ma la banda dei ragazzini è sempre lì che passa saltellando, sotto quello scorcio del Ponte di Brooklyn, senza invecchiare, nell’istante sospeso in cui lo sparo non arriva mai.
Paolo Marcacci







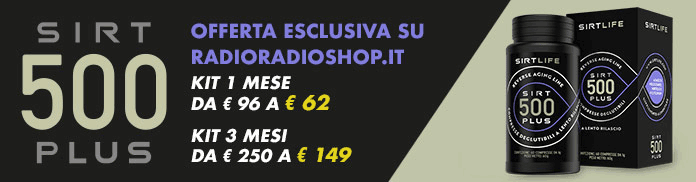







![Putin smentisce tutti sugli ATACMS – “nessun danno” – e avverte NATO e Stati Uniti [Sub. Ita]](https://www.radioradio.it/media/2024/11/putin-guerra-100x70.png)







