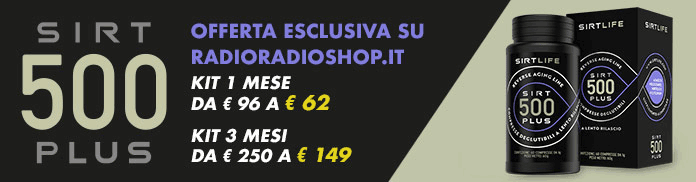Deve essere vero che la vita di ognuno è, in fondo, un eterno ritorno. Che prima o poi ci si ritrova di fronte a ciò che si è stati, avendo però coperto tutta un’orbita ellittica, a livello esistenziale: allontanarsi il più possibile da se stessi per poi ritrovarsi, riavvicinandosi. Poi, c’è la boxe, come metafora della solitudine che diventa assoluta di fronte ai rovesci della sorte e agli errori che un individuo commette, veri o presunti che siano stati.
– Il pugile al tappeto è l’uomo più solo al mondo – ebbe a dire un giorno Gene Tunney: se è vero per ciò che accade sul quadrato, lo è molto di più al di fuori delle sedici corde.
Tutte le vite di Mike Tyson, quelle che ha vissuto potendone scegliere soltanto una parte, gli si sono accartocciate addosso come gli arabeschi del suo tatuaggio attorno all’occhio. Ha allevato felini, regalato Rolls Royce alle pattuglie che lo hanno fermato, coperto di soldi i secondini in carcere perché evitassero che gli altri detenuti lo provocassero lanciandogli buste di urina ed escrementi; è arrivato a essere obeso, si è fatto piovere addosso debiti ingenti e lutti annichilenti come chi esca di casa senza ombrello dopo aver sentito i tuoni. E l’ultima volta che era salito sul quadrato, l’undici luglio del 2005, sconfitto al temine della sesta ripresa per KO tecnico da Kevin McBride, uno che qualche anno prima non sarebbe stato degno nemmeno di portargli la vestaglia, aveva voluto far subito sapere alla gente di aver appreso una lezione, essenzialmente: che giunti a un certo punto non si può continuare a mentire a se stessi.
Ed è in ragione di quella stessa franchezza che oggi l’uomo, seguito da pugile, ha scelto di tornare: per raccontarsi un altro pezzo di verità, col dettaglio degli addominali tornati in rilievo, dei pettorali di nuovo alti. Quella verità che aveva fatto in modo di non ascoltare, troppe volte, come facciamo tutti.
Come quella volta, con quel custode del Cimitero Monumentale di Las Vegas, quando Tyson era andato a rendere omaggio alla tomba di Sonny Liston, ossia l’uomo che più di ogni altro era sempre rimasto solo con la propria rabbia, anche una volta raggiunta la gloria. L’inserviente fece finta di non riconoscerlo e, di fronte alla sua domanda, gli rispose, come fosse un monito; – Cerchi la tomba di Liston? Semplice, è quella senza fiori. –
Paolo Marcacci